Uomo e ambiente: nel libro di Descola la scissione non è più possibile
Come si relaziona l’uomo all’ambiente? E come cambia questo rapporto in un’epoca di cambiamenti climatici, inquinamento, disastri naturali? Dalla fine del XIX secolo, l’antropologia studia l’umanità nella diversità delle sue manifestazioni e, senza sfuggire alla suddivisione tra natura e cultura, si divide tra due linee interpretative: la prima considera le diversità culturali come risposte adattative ai condizionamenti dell’ambiente e la seconda si sofferma invece sul ruolo simbolico di elementi naturali selezionati nell’ambiente circostante. Nel saggio “L’ecologia degli altri“, da poco pubblicato da Linaria, l’antropologo francese Philippe Descola esorta a uscire da questo dualismo, invitando a ripensare il rapporto tra natura e cultura e dunque il ruolo dell’uomo nell’ambiente che lo circonda. Per la rubrica “Racconti d’Ambiente“, pubblichiamo un estratto delle Conclusioni del volume.
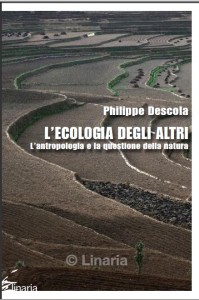 Non è necessario essere grandi esperti per predire che la questione del rapporto degli umani con la natura sarà assolutamente cruciale in questo secolo. Basta guardarci intorno per rendercene conto: gli sconvolgimenti climatici, l’erosione della biodiversità, la moltiplicazione degli organismi transgenici, l’esaurimento delle energie fossili, l’inquinamento di fragili ecosistemi e megalopoli, la scomparsa accelerata delle foreste della zona intertropicale, tutto questo è diventato oggetto di dibattito pubblico su scala planetaria e alimenta nel quotidiano le inquietudini di molti abitanti del pianeta. Allo stesso tempo, è diventato difficile continuare a credere che la natura sia un ambito del tutto separato dalla vita sociale, un’ipostasi che assume, secondo le circostanze, le vesti di una madre nutrice, di una matrigna piena di rancore o di una bella misteriosa da svelare, un ambito che gli umani tentano di comprendere e di controllare e che non manca di far sentire i propri capricci, ma che costituisce in sostanza un campo di regolarità autonome nel quale i valori, le convenzioni e le ideologie non trovano posto. Questa immagine è ormai abolita: dove si ferma la natura e dove comincia la cultura nel surriscaldamento climatico, nella diminuzione dello strato di ozono, nella produzione di cellule specializzate a partire da cellule totipotenti? Si capisce bene che la questione non ha più senso. Soprattutto, al di là dei molteplici interrogativi etici che suscita, questo nuovo stato di cose sconvolge antiche concezioni della persona umana e delle sue componenti, come anche il processo di costruzione dell’identità individuale e collettiva; o perlomeno, questo accade nel mondo occidentale dove, a differenza di quello che succede altrove, eravamo abituati a distinguere piuttosto nettamente il naturale dall’artificiale, sia nell’uomo che nel suo ambiente. In altri continenti come la Cina e il Giappone, dove l’idea di natura è sconosciuta e dove il corpo umano non è concepito come segno dell’anima e riproduzione di un modello trascendente – creazione divina nel passato, genotipo oggi – questo genere di problema non si pone.
Non è necessario essere grandi esperti per predire che la questione del rapporto degli umani con la natura sarà assolutamente cruciale in questo secolo. Basta guardarci intorno per rendercene conto: gli sconvolgimenti climatici, l’erosione della biodiversità, la moltiplicazione degli organismi transgenici, l’esaurimento delle energie fossili, l’inquinamento di fragili ecosistemi e megalopoli, la scomparsa accelerata delle foreste della zona intertropicale, tutto questo è diventato oggetto di dibattito pubblico su scala planetaria e alimenta nel quotidiano le inquietudini di molti abitanti del pianeta. Allo stesso tempo, è diventato difficile continuare a credere che la natura sia un ambito del tutto separato dalla vita sociale, un’ipostasi che assume, secondo le circostanze, le vesti di una madre nutrice, di una matrigna piena di rancore o di una bella misteriosa da svelare, un ambito che gli umani tentano di comprendere e di controllare e che non manca di far sentire i propri capricci, ma che costituisce in sostanza un campo di regolarità autonome nel quale i valori, le convenzioni e le ideologie non trovano posto. Questa immagine è ormai abolita: dove si ferma la natura e dove comincia la cultura nel surriscaldamento climatico, nella diminuzione dello strato di ozono, nella produzione di cellule specializzate a partire da cellule totipotenti? Si capisce bene che la questione non ha più senso. Soprattutto, al di là dei molteplici interrogativi etici che suscita, questo nuovo stato di cose sconvolge antiche concezioni della persona umana e delle sue componenti, come anche il processo di costruzione dell’identità individuale e collettiva; o perlomeno, questo accade nel mondo occidentale dove, a differenza di quello che succede altrove, eravamo abituati a distinguere piuttosto nettamente il naturale dall’artificiale, sia nell’uomo che nel suo ambiente. In altri continenti come la Cina e il Giappone, dove l’idea di natura è sconosciuta e dove il corpo umano non è concepito come segno dell’anima e riproduzione di un modello trascendente – creazione divina nel passato, genotipo oggi – questo genere di problema non si pone.
È quindi soprattutto in Europa che lo sviluppo delle biotecnologie genera inquietudini, testimoniando il disagio provocato dalla profonda riconsiderazione delle credenze e delle norme che organizzano il rapporto con la natura. Altrove, sono piuttosto i cambiamenti climatici e ambientali che rimettono in discussione le abitudini di vita e i modi di pensare. Ora, che siano fondate o fantastiche, queste paure si lasciano raramente addomesticare dalle spiegazioni degli studiosi; in primo luogo perché queste spiegazioni non sono accessibili a tutti, ma anche e soprattutto perché il comportamento dei cittadini del mondo nei confronti di tali questioni origina da substrati culturali diversificati, la cui formazione e il cui sviluppo sono relativamente autonomi rispetto alle acquisizioni delle scienze, perfino nelle nazioni industrializzate. È questo genere di substrato che l’antropologia ha iniziato a studiare, non tanto per tentare di rispondere a «richieste sociali» (l’accettabilità di tale o talaltra tecnica biologica, di questo o quel modo di combattere contro l’effetto serra), ma piuttosto perché è diventato ormai indispensabile riflettere sugli effetti che in Occidente conducono alla disgregazione del naturale, collocando questo problema in un contesto più generale in cui si esaminino le diverse concezioni della dimensione biologica dell’uomo e del rapporto con l’ambiente fisico che si sono potute sviluppare qua e là nel corso della storia. (…)
In sintesi, la critica dell’opposizione tra natura e cultura che ho intrapreso comporta un ampio rimaneggiamento degli strumenti concettuali impiegati per pensare i rapporti tra oggetti naturali ed esseri sociali. Infatti, non basta dimostrare che tale opposizione è inesistente per molte società premoderne, o che questa compare tardi nello sviluppo del pensiero occidentale. Occorre poterla integrare in un nuovo ambito analitico all’interno del quale il naturalismo moderno, lungi dal costituire il campione che permette di giudicare culture distanti nel tempo o nello spazio, non risulta altro che una delle espressioni possibili di schemi più generali che governano l’oggettivazione del mondo e dell’altro. Ora, messi di fronte all’esistenza di una moltitudine di «corpi associati», per riprendere una formula di Merleau-Ponty, gli uomini si sono sforzati di organizzare le relazioni che intrattengono con queste entità secondo formule sociali che si possono ritenere in numero limitato. Si tratta innanzitutto di una scelta concernente la posizione dei confini ontologici, e dunque la struttura delle cosmologie: le continuità tra umani e non umani trattate secondo un unico regime di socialità, il transfert analogico delle proprietà degli oggetti naturali alle tassonomie sociali, la corrispondenza o azione a distanza tra elementi del macrocosmo e elementi del microcosmo, la separazione tra la sfera degli uomini e il resto del mondo e così via. Si tratta poi di sistemi di valore che orientano i rapporti pratici con l’altro, umano e non umano, e che, quando acquisiscono localmente una posizione dominante, conferiscono a una società il suo stile distintivo: l’esigenza di reciprocità, l’appropriazione predatrice, il dono disinteressato, la protezione, la produzione, ecc. Si tratta infine di dispositivi di classificazione grazie ai quali gli elementi del mondo vengono ripartiti in nomenclature più o meno estensive. Si può ipotizzare che tutti gli schemi di cui dispone l’umanità per definire le sue relazioni con il mondo e con l’altro esistano sotto forma di strutture mentali, in parte innate, in parte originate dalle proprietà stesse della vita sociale. Ma queste strutture non sono tutte compatibili tra loro, e ogni sistema culturale, ogni tipo di organizzazione sociale è il prodotto di una selezione e di una combinazione che, per il fatto di essere contingenti, si sono spesso ripetute nella storia con risultati comparabili. Specificare la natura di questi elementi, delucidare le loro regole di composizione e stabilire una tipologia dei loro accomodamenti sono i compiti che l’antropologia dovrebbe assegnarsi in via del tutto prioritaria.
Philippe Descola*
*Docente di Antropologia della natura al College de France, direttore del dipartimento del Laboratoire d’Anthropologie Sociale fondato da Claude Lévi‐Strauss e professore presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi. Di recente i suoi interessi si sono rivolti al rapporto tra le comunità umane e i sistemi ecologici sul quale ha scritto Par‐delá nature et culture uscito nel 2005. Fra i suoi libri anche La nature domestique (1986), Les Lances du crépuscule (1993), Nature and Society (1996).







